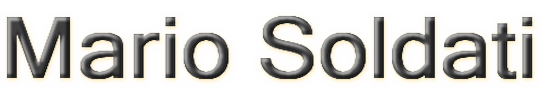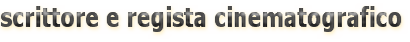|
Soldati assistente di Camerini in Africa negli anni Trenta |
|
Anno di pubblicazione 1935 |
Prima edizione, Milano Corticelli 1935 ( Soldati usa lo pseudonimo di Franco Pallavera)
Palermo Sellerio 1985
“ “ 2003
Nota di Guido Davico Bonino
Come Soldati stesso ha ricordato nel corso di una sua Conversazione in una stanza chiusa di e con Davide Lajolo (Milano, Frassinelli, 1983), 24 ore in uno studio cinematografico è stato scritto nel 1934-35, nel corso di un “esilio forzato” sul lago d’Orta, diviso con un “carissimo amico” , Mario Bonfantini.
Alle spalle del giovane scrittore, che, dopo un biennio alla Columbia University di New York, ha rinunciato all’America e alle proprie ambizioni di docente universitario di storia dell’arte, ci sono tre anni di duro apprendistato cinematografico a Roma, dal 1931 al ’34. “ Io nel ’31 ho cominciato facendo il ciacchista, l’aiuto, il segretario d’edizione, insomma, la gavetta. Era umiliante. Poi sono diventato amico di Mario Camerini, quindi di altri straordinari professionisti come Terzano, Solaroli e molti altri che mi hanno insegnato tutto. E col tempo sono passato alla sceneggiatura e all’aiuto regia…”.
E’ proprio un incidente come sceneggiatore ad allontanare provvisoriamente dagli studi e dagli uffici della Cines l’allora ventottenne Soldati: il fiasco di Acciaio del “famoso regista tedesco” Walter Ruttmann, con cui ha riscritto, a quattro mani, un copione originariamente firmato, con cattivi risultati, da Luigi Pirandello: “ Era un bellissimo film, un film, come si dice oggi, d’autore, con danze e figure di macchine, di acciaierie, qualcosa di spettacolare. Ma fu anche un fiasco finanziario, non piacque, e io ne feci le spese. Cecchi mi chiamò, sapevo bene che la colpa non era mia, ma avevano bisogno di un colpevole alla Cines, e così venni licenziato in tronco. Senza liquidazione, senza niente… Era nel 1934, e dovevo vivere con meno di 200 lire al mese. Così per occupare quell’esilio forzato, ho ricominciato a scrivere”.
Nasce così, dunque, il libro che qui si ristampa, pubblicato a Milano presso Corticelli sotto lo pseudonimo di Franco Pallavera. Se non sbagliamo, insieme ad una giovanile prova teatrale ( Pilato, 1925), è il solo libro di Soldati che non ha più visto la luce, dopo l’edizione originaria.
Eppure è un’operina di straordinaria vivezza, che, a nostro avviso, in questi cinquant’anni non ha perso nulla del suo fascino. La si potrebbe chiamare, alla francese, un cinéroman: nel senso proprio di un “romanzo del cinema” italiano Anni Trenta.
Pur avendo accettato di scrivere una guida all’inedito (allora) mondo del cinema, il giovane narratore di Salmace, lo smagliante diarista di America primo amore (usciti, rispettivamente, nel 29 e nel 35) non rinuncia affatto alle ambizioni letterarie: si direbbe, anzi, che badi a convertire i propositi saggistici in continue occasioni narrative, facendo dei dodici capitoli del suo manualetto altrettanti scomparti di un racconto, concepito e portato innanzi come tale.
Il primo, Risveglio, è addirittura un piccolo gioiello di prosa vagamente liberty: con quella silhouette di “ diva dello schermo o stella” che si scaraventa giù dal letto all’alba, “ i biondi riccioli sfatti e appiattiti”, sciabatta sgraziatamente verso la doccia, caracolla sui tacchi attraverso i deserti corridoi di un albergo, si rincantuccia sonnacchiosa e triste nell’angolo di un taxi: ed è già “ sotto i ferri del parrucchiere alle sette in punto”, mentre un silenzio fondo aleggia ancora nei “ cortili vuoti “ dello Stabilimento.
Il secondo, I visi di terracotta, con le sue puntigliose precisazioni sul trucco (il cerone verde, poi marrone, poi rosa) sembra tendere piuttosto al manualistico: ma poi tutti i dettagli, garbatamente nozionistici, s’aggrumano in un immagine di straziante ironia: quella di crudele entomologo, della diva che si fa gli occhi da sé, “ con una speciale pinza appiattita e ricurva e scaldata alla fiamma ”, afferrando, torcendo, premendo le ciglia, sino ad ottenerne di nuove, “ più grosse, più lucide, più rade e più visibili che in natura “. E ancora un immagine, francamente comica stavolta, è quanto ti si imprime nella memoria dopo aver letto Luce rossa: si gira, accurata descrizione di un teatro di posa: quella del Direttore e dello scenografo che “ litigano, passeggiando su e giù per la scena, che rappresenta il salotto di una villa signorile”, per via di un uscio a vetri che, per sbaglio, si è trasformato, nottetempo, in una veranda.
Nel quarto capitolo Si gira? la volontà di far letteratura, di tradurre espressivamente un fatto molto tecnico e specifico, cioè l’avvio, continuamente interrotto di una ripresa, mi pare lampante. L’evocazione, in “ un’aria d’artificio, d’irrealtà trasposta quasi in un altro mondo”, di quella “ Casa del Sonno”, di quel “piccolo Erebo” che è uno studio cinematografico, prende corpo sulla pagina in un registro stilistico che oscilla volutamente tra l’ironia e il mistero (“… uomini fermi, fissi nelle più strane posizioni e vestiti nelle foggie più diverse …”): ma poi, sul finale, è l’ironia, affettuosamente, a prevalere, dinnanzi all’ennesimo sfibrante rinvio: “ Si ricade nell’attesa. Quando entrammo in teatro, due ore fa, questa medesima scena era già stata provata e riprovata, ed era sul punto di venir girata. Due ore sono passate, e la sena non è stata girata due volte per intero”.
Rifiutando di scrivere un libro “ordinato e metodico sul cinematografo”, Soldati punta a restituirci “l’impressione viva, disordinata, tumultuosa … della lavorazione cinematografica” affidandosi agli estri, addirittura agli scatti di un’alacre inventiva. Tiene, certo, d’occhio le esigenze di un’ordinata esposizione: ma ciò che davvero lo stimola, a ben leggere, è la possibilità d’innestarvi, all’improvviso, una gustosa situazione narrativa, quando non, addirittura, d’imboccare la diversione fantastica. Si guardi, nel quinto capitolo Non si gira ancora, all’idea fissa del film come “commedia fotografata”, che dura nella finzione quanto nella realtà, ben radicata nelle “contadine” o alle “operaie” di “certi borghi delle nostre campagne”; o nel successivo Il Direttore crea (oltre al profilo del regista, appunto, “pensoso, nervoso, rannuvolato, per la scena oscura e deserta”) a tutte le sequenze di prova, che sono altrettante micro commedie di franca immediatezza. E non è forse un calcolato “ fuor d’opera” il settimo capitolo A tavola coi divi, con quella “strana accozzaglia di fogge e di visi” da far la delizia del Woody Allen di Broadway Danny Rose, seguita a ruota da una dimostrazione, tra il serio e il faceto ( “Viaggiano forse i capistazione? Sono ghiotti i cuochi?” ) secondo cui “ la vita libertina degli ambienti cinematografici è una nostalgica invenzione dei bravi papà e delle brave figliuole”?
Certo l’operina ( metto le mani avanti per non impensierire i molti giovani cinéfili, che vi si accosteranno per la prima volta) contiene molte assennate precisazioni non solo d’ordine tecnico, ma financo estetico: ed alcune mi paiono, se la mia incultura in materia non mi tradisce, persino anticipatrici: l’idea che “l’artificio, sempre, è alla base del cinema”, che “ il cinematografo talvolta è arte, ma è sempre industria”, e quella ancora, che a me sembra particolarmente avvincente, della creatività filmica come sempre “aperta”, in continua metamorfosi e costante aggiustamento: “Le parole giuste si trovano cambiando continuamente, provando e riprovando”.
Ma, dico la verità, sarei disposto a permutare queste ed altre intelligenti notazioni con quel piccolo gioiello che potremmo intitolare, tanto per intenderci, La storia di Mariuccia: un altro inserto, che potremmo tranquillamente estrapolare dal libro senza alcun danno alla compagine saggistica, ma che è bello, a mio giudizio, quanto i più bei racconti del primo Soldati: “ Cominciamo in famiglia. Uno zio, o una zia compiacente; forse una sorella maggiore; forse la stessa madre… ”. Mariuccia la sartina, Mariuccia l’operaia, percossa una domenica sera dalla scintilla della vocazione, e finalmente, “una bella mattina di primavera”, in partenza con la mamma per Roma; Mariuccia che fa lunghe interminabili code nelle “tetre stanzette” degli Stabilimenti sino alla “grande disgrazia” del provino, che le frutta “subito una piccola parte della durata di tre o quattro giorni” e la condanna per il resto della vita a “diventare una generica di terza categoria” è non solo l’invenzione di uno scrittore di sicuro talento: è uno di quei profili muliebri tipici dell’ispirazione più schietta di Soldati, tra ironia e tenerezza, tra sarcasmo e pietà.
Settembre 1985